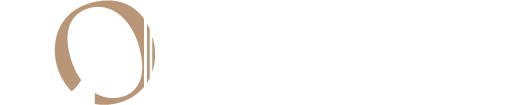Il padre e la madre (o il tutore) sono responsabili dei danni cagionati dal fatto illecito dei figli minori, che abitano con essi (art. 2048 codice civile). Si tratta di una responsabilità indiretta che si fonda su una loro colpa nell’educazione (culpa in educando) e, di conseguenza, sono tenuti a risarcire i danni subìti dalla vittima.
I criteri in base ai quali va imputata ai genitori la responsabilità per gli atti illeciti compiuti dai figli minori consistono sia nel potere-dovere di esercitare la vigilanza sul comportamento dei figli stessi, in relazione al quale assume rilievo determinante il perdurare della coabitazione, sia anche, e soprattutto, nell’obbligo di svolgere un’adeguata attività formativa, impartendo ai figli l’educazione al rispetto delle regole della civile coesistenza, nei rapporti con il prossimo e nello svolgimento delle attività extra-familiari.
Come per gli illeciti civili anche per gli illeciti amministrativi commessi dai figli minorenni ne rispondono i genitori.
Il processo penale del minore
Per quanto riguarda i profili penali, l’art. 27 della Costituzione sancisce che la responsabilità penale è personale (nessuno, se non l’autore del reato, può essere chiamato a risponderne).
Da qui il processo penale del minore che viene regolato da apposite fonti normative (D.P.R. 448/1988) ed ha un regime differenziato rispetto a quello degli adulti.
Il processo minorile si incentra sulla persona che ha commesso il reato, più che sul fatto-reato, e l’accertamento dello stesso costituisce l’occasione per lavorare sulla responsabilizzazione del soggetto minorenne, favorendo la riparazione dei danni da questo generati.
Si ritiene infatti che i minori, avendo una personalità ancora in via di sviluppo, avranno una maggiore probabilità di allontanarsi dalle condotte illecite e deplorevoli se si antepone la loro rieducazione e se ne facilita il reinserimento nell’ambiente sociale e familiare, supportando la consapevole scelta di cambiamento dei ragazzi.
La responsabilizzazione del minore e la condivisione di valori positivi costituiscono le basi su cui lavorare per la prevenzione della commissione di futuri reati.
Per questo motivo il codice del processo penale minorile prevede alcuni istituti peculiari (rispetto al rito destinato agli imputati adulti):
- proscioglimento per irrilevanza del fatto;
- sospensione del processo con messa alla prova;
- perdono giudiziale.
Proscioglimento per irrilevanza del fatto
Questo istituto tende a porre fuori dal circuito penale il minore in modo anticipato, evitando gli effetti pregiudizievoli che il processo inevitabilmente comporta. Qualora venga accertato che il minore abbia realizzato la fattispecie astratta di reato contestata, si potrà comunque giungere ad una sentenza di improcedibilità alla presenza di tre condizioni:
- il fatto deve essere tenue;
- il comportamento occasionale;
- e vi deve essere il rischio che la prosecuzione del processo pregiudichi le esigenze educative dello stesso.
In pratica, nonostante il comportamento, seppur penalmente rilevante in astratto, viene in questi casi considerato penalmente “irrilevante” e viene di conseguenza riconosciuta applicabile la presente causa di non punibilità. Norma a cui si può addire in tutti quei casi in cui si tratti di reati di scarso allarme sociale, che rappresentano episodi isolati nella vita del minore.
Sospensione del processo con messa alla prova
Tale procedura consente, sempre dopo aver verificato l’effettiva responsabilità penale del minore, di osservare al di fuori dell’ambiente processuale l’evoluzione che la personalità dell’imputato può intraprendere verso modelli positivi grazie all’aiuto esterno dei servizi sociali o di altri soggetti.
Il processo è così sospeso per un periodo che varia a seconda della gravità del reato commesso, e il minore inizia un percorso rieducativo ed evolutivo. Il giudice all’esito della messa alla prova è chiamato a fare una valutazione sulla crescita effettuata dal minore tale da giustificare la rinuncia della pretesa punitiva.
Si badi bene. Durante il periodo di sospensione il minore è affidato ai servizi sociali minorili e destinatario di specifiche prescrizioni impartite dal giudice volte anche a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la riconciliazione con la persona offesa.
Il giudice, quindi, se ritiene che la prova abbia dato esito positivo, dichiara con sentenza estinto il reato.
Perdono giudiziale
Il giudice pur avendo accertato la responsabilità dell’imputato, può decidere di concedere il perdono giudiziale e dunque pronunciare una sentenza di proscioglimento, qualora la pena in concreto applicabile non sia una pena detentiva superiore nel massimo a due anni di pena detentiva ovvero una pena pecuniaria superiore ad € 1.549,00, anche se congiunta a pena detentiva, e a condizione che il colpevole non sia già stato precedentemente condannato a pena detentiva per delitto o dichiarato delinquente o contravventore abituale o professionale.
Condizione imprescindibile è poi che si ritenga ragionevolmente, sulla base dei criteri di cui all’art. 133 c.p. sul disvalore dell’azione perpetrata, che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati così che la mancata irrogazione della pena in concreto contribuisca al suo recupero personale e sociale.
Processo a minori e vittime
Nel processo penale minorile non è permessa la costituzione di parte civile della persona offesa, che può comunque partecipare al processo penale esercitando le facoltà previste dall’art. 90 c.p.p. (tra cui, in particolare, il deposito di memorie difensive e l’indicazione di mezzi di prova).
A questo si aggiunga che nell’ambito del processo penale spesso si instaura un percorso di mediazione penale, che ha quale scopo il raggiungere una riappacificazione con la vittima, che vada a ripercuotersi positivamente sull’intera società, favorendo altresì il recupero e la riabilitazione del colpevole.
In ogni caso il danneggiato potrà, però, far valere le proprie pretese risarcitorie in un separato e apposito giudizio civile.